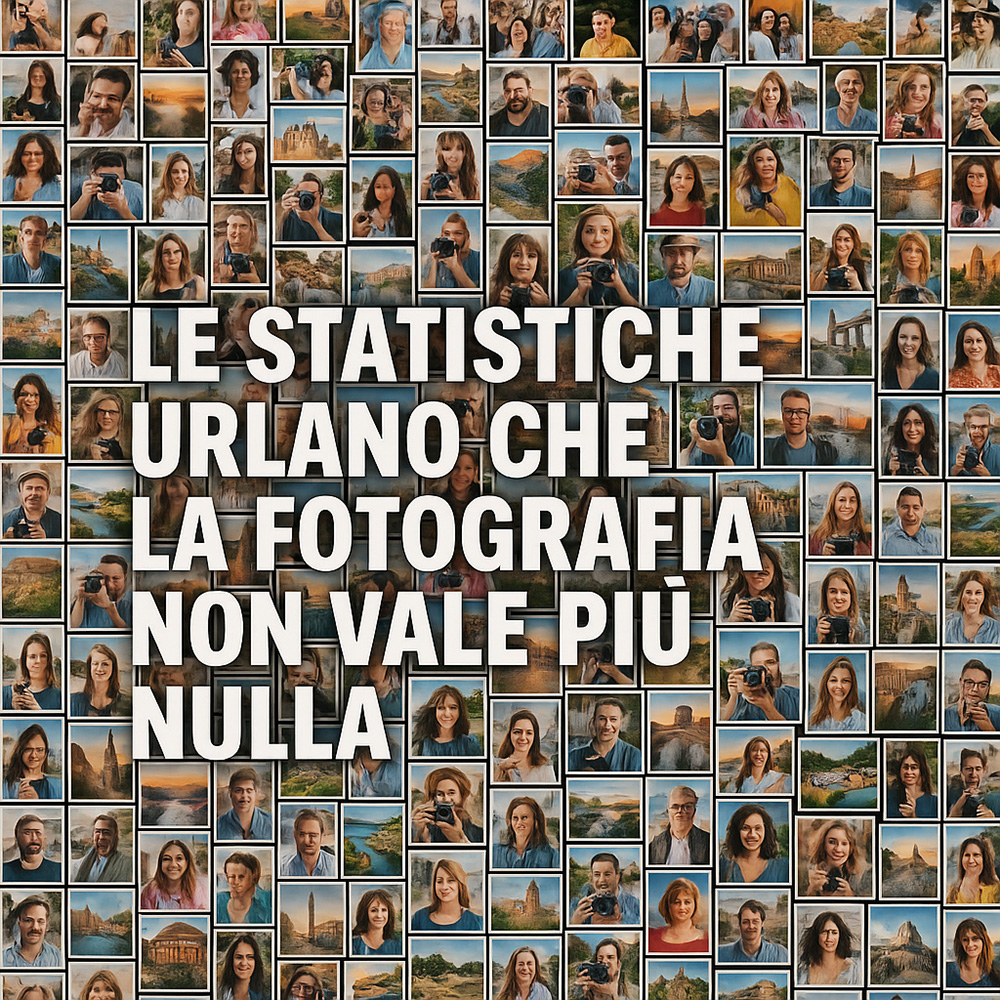Ho iniziato a riflettere seriamente sul “peso” (o meglio, sulla leggerezza) della fotografia ai nostri giorni e su quanto i numeri degli scatti che produciamo ci stiano raccontando una storia ben diversa da quella che ci piace credere. Nel corso degli ultimi dieci anni, la fotografia è passata dall’essere un’arte e un mestiere – con tutta l’attesa, la cura e la selezione che comportava – a un gesto compulsivo e quasi istintivo. E mentre l’umanità preme il pulsante di scatto in modo più frenetico che mai, a me sembra che il valore intrinseco di quegli istanti fissati stia evaporando sotto i nostri occhi. photosecrets.comriseaboveresearch.com
Dati e statistiche: un decennio di foto (2010‑2024)
Per avere un quadro chiaro dell’esplosione di immagini prodotte, ho ricostruito una serie storica dei miliardi di foto scattate ogni anno a livello globale. Ho unito i dati di InfoTrends fino al 2020 e quelli di fonti più recenti per il periodo 2021‑2024:
| Anno | Foto scattate (miliardi) |
|---|---|
| 2010 | 350 |
| 2011 | 380 |
| 2013 | 650 |
| 2014 | 810 |
| 2015 | 1 000 |
| 2016 | 1 100 |
| 2017 | 1 200 |
| 2018 | 1 330 |
| 2019 | 1 440 |
| 2020 | 1 150 |
| 2021 | 1 200 |
| 2022 | 1 710 |
| 2023 | 1 810 – 1 600* |
| 2024 | 1 940 |
*Per il 2023 si segnalano due stime leggermente diverse: ~1,81 trilioni secondo Photutorial photutorial.com e ~1,6 trilioni secondo Rise Above Research riseaboveresearch.com.
Ogni cifra è un promemoria dell’accelerazione vertiginosa impressa dagli smartphone: nell’arco di un decennio siamo passati da poche centinaia di miliardi a quasi due trilioni di immagini all’anno. E se pensiamo che il 2025 dovrebbe superare i 2 trilioni di scatti, con proiezioni di oltre 2,3 trilioni entro il 2028 riseaboveresearch.com, capiamo subito che non stiamo parlando di numeri “tondi” ma di fenomeni che hanno raddoppiato o triplicato ogni precedente record.
1. Dalla cura alla quantità: l’avvento dello smartphone
Non c’è dubbio: il motore principale di questa valanga di pixel è il telefonino. La diffusione capillare di device sempre più performanti – con sensori che oggi raggiungono regolarmente i 100 MP, funzioni di stabilizzazione ottica, modalità notturna e intelligenza artificiale per ottimizzare scatto e post‑processing – ha trasformato ogni utente in un fotografo potenziale direporter.com. Nel 2015, già l’80 % degli scatti veniva effettuato con dispositivi mobili photosecrets.com; oggi la percentuale è ulteriormente salita, lambendo quasi il 90 % delle immagini prodotte quotidianamente.
Questo passaggio dal “fotografo con macchina” all’“utente con smartphone” ha innescato una rivoluzione culturale: non servono più corsi di fotografia, tempi di posa o sviluppo. Basta aprire l’app, inquadrare, toccare lo schermo e condividere. Il risultato? Un numero talmente vasto di file che risulta praticamente impossibile dare loro un valore, riconoscerne i pregi o persino conservarli in modo significativo. Eppure, fino a non troppi anni fa, la fotografia era un atto di misura: selezione delle lenti, riflessione sulla composizione, scelta accurata del momento da fissare. Oggi, la misura è rappresentata dal contatore degli scatti inutili, non da quelli memorabili.
2. L’illusione del valore: perché “tanto non vale niente”
Le statistiche parlano chiaro: più foto vengono scattate, meno ognuna di esse vale. È un paradosso quasi matematico, dove l’abbondanza inquina la percezione del valore. In termini economici, il mercato della fotografia stock, un tempo terreno fertile per guadagni passivi, ha visto nel 2023 ricavi globali di circa 650 milioni di dollari – un dato che, pur significativo, sembra risicato se comparato al volume di immagini offerte ogni anno wifitalents.com. Diventa ancor più evidente pensando che Instagram oggi ospita oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili e si caricano più di 95 milioni di foto al giorno worldmetrics.org: l’eccesso di offerta annienta ogni possibilità di guadagno consistente, se non attraverso meccanismi esclusivi (collezioni curate, NFT, produzioni editoriali).
Del resto, chiunque può produrre una fotografia “sufficientemente buona” con un clic, ma trovare quella che cattura davvero l’attenzione – che comunica un’emozione o racconta una storia autentica – richiede ancora competenza e tempo. È la differenza tra lo scatto compulsivo e il vero scatto: il primo è gettito in un mare di pixel, il secondo resta impresso nella memoria collettiva.
3. L’era della condivisione: dal privato al pubblico in un tap
Parallelamente all’aumento di volume, è esplosa la condivisione. Le statistiche indicano che ogni secondo vengono pubblicate sulle piattaforme social oltre 1 milione di immagini wifitalents.com. Questo flusso ininterrotto genera un “rumore fotografico” che rende difficilissimo emergere, anche per fotografi professionisti: la cura editoriale è stata sostituita dall’immediatezza del click-to-share, mentre i feed social premiano la frequenza degli aggiornamenti piuttosto che la qualità.
Il meccanismo di gratificazione istantanea – like, commenti, share – alimenta l’illusione che ogni foto sia un’opera d’arte, ma nella maggior parte dei casi si tratta di merce di scambio: uno scatto per un like. In questo contesto, il valore intrinseco dell’immagine è declassato a unità di scambio sociale, non più a testimonianza o narrazione personale.
4. La crisi dell’archiviazione e la sindrome dell’oblio
Con trilioni di file da salvare, anche la gestione dei ricordi si sta trasformando in un problema logorante. Rise Above Research stima che in cloud, device e supporti vari siano archiviati quasi 10 trilioni di foto nel 2023 riseaboveresearch.com. Tuttavia, quanti di noi rivedono davvero le proprie immagini? Pochissimi: la maggior parte delle raccolte private rimane intonso, sepolto sotto backup automatici che occuperanno sempre più spazio.
È la “sindrome dell’oblio”: ho scattato, ho archiviato, ma non ho il tempo – o la motivazione – per rivivere quei momenti. Di conseguenza, la fotografia smette di essere memoria e diventa semplice archivio: un magazzino digitale di file ai quali non attribuiamo più alcun valore affettivo né estetico.
5. La qualità contro la quantità: chi vince?
Mi sorprendo ogni volta nel constatare quanto sia raro trovare un’immagine che mi colpisca davvero, nonostante io scrolli centinaia di post al giorno. Il confronto tra scatto professionale e foto da smartphone è impietoso: il primo racconta una visione, il secondo è spesso solo documentazione veloce. Eppure, statistiche recenti mostrano che oltre il 60 % dei nuovi fotografi impara tramite tutorial online e app di editing come VSCO o Lightroom wifitalents.com, mentre il 40 % delle immagini post‑produzione utilizza filtri creativi per aumentare l’engagement sui social worldmetrics.org.
Il paradosso è che, pur avendo più strumenti che mai, la vera competenza fotografica sembra in declino: l’algoritmo premia la ripetizione del gesto più che l’ispirazione. La “maestria” rischia di diventare un optional, non più una condizione necessaria.
6. L’influenza dell’AI: opportunità e sfide
In questo scenario di saturazione visiva, l’intelligenza artificiale emerge come possibile salvezza (o ulteriore complicazione). Già oggi esistono servizi che analizzano automaticamente le librerie di foto, suggerendo le immagini più significative e persino creando video‑montaggi intelligenti riseaboveresearch.com; in futuro potremo contare su sistemi capaci di riconoscere emozioni, contesti e storie all’interno di milioni di scatti.
Da un lato, l’AI offre la possibilità di riscoprire “perle nascoste” e di valorizzare ciò che altrimenti sarebbe sepolto; dall’altro, rischia di uniformare ulteriormente lo stile: se tutti useranno algoritmi simili per scegliere e modificare le foto, come faranno gli scatti a distinguersi? Il rischio è di sostituire il giudizio umano con quello del codice, trasformando la fotografia in un prodotto sempre più standardizzato.
7. Il futuro della fotografia: scarsità, NFT e metaverso
Per recuperare valore, la parola chiave sarà scarsità. Già assistiamo all’ascesa degli NFT fotografici, che attribuiscono unicità e proprietà verificabile a un’immagine digitale. Allo stesso modo, nel metaverso e negli spazi virtuali, le fotografie potranno diventare elementi rari di decorazione o racconto, con edizioni limitate e percezioni esclusive.
In futuro, potremmo vedere “collezioni fotografiche” curate da esperti – in stile gallerie digitali – dove ogni scatto ha un destinatario consapevole e disposto a investire. L’idea di “fotografia come prodotto di massa” lascerà spazio a una dimensione più selettiva, dove il valore sarà legato alla storia dietro lo scatto e alla qualità dell’esperienza visiva.
8. Riflessioni finali: recuperare il valore perduto
Guardando ai numeri, è chiaro che la fotografia non “vale più niente” nel senso tradizionale del termine: l’abbondanza di immagini ha eroso la percezione del loro valore intrinseco. Ma proprio in questo contesto emerge un’opportunità: rivalutare ogni scatto non come un dato da catalogare, ma come un racconto unico da condividere con cura.
Personalmente, sento l’urgenza di ristabilire un rapporto più consapevole con la fotocamera (qualsiasi essa sia) e con chi vedrà le mie immagini. Ciò significa tornare a selezionare, a raccontare una storia, a cercare l’impatto emotivo. Solo così potremo trasformare nuovamente la fotografia da gesto compulsivo a strumento di comunicazione profonda e memorabile.
Con questa analisi spero di aver sollevato domande più che fornito risposte definitive: i numeri sono impressionanti, anzi schiaccianti, ma spetta a noi decidere se essere semplici generatori di pixel o narratori di racconti visivi. La sfida del prossimo decennio sarà creare scarsità in un mondo dove lo “scatto compulsivo” domina ancora. E io, per parte mia, sono pronto a coglierla.
CAVIGE
Carriere Vito Gerardo / Graphics / WEB / Photography / Drone